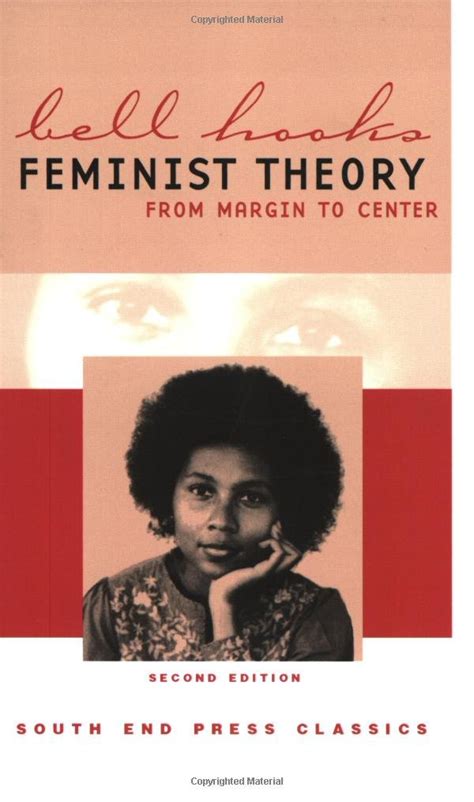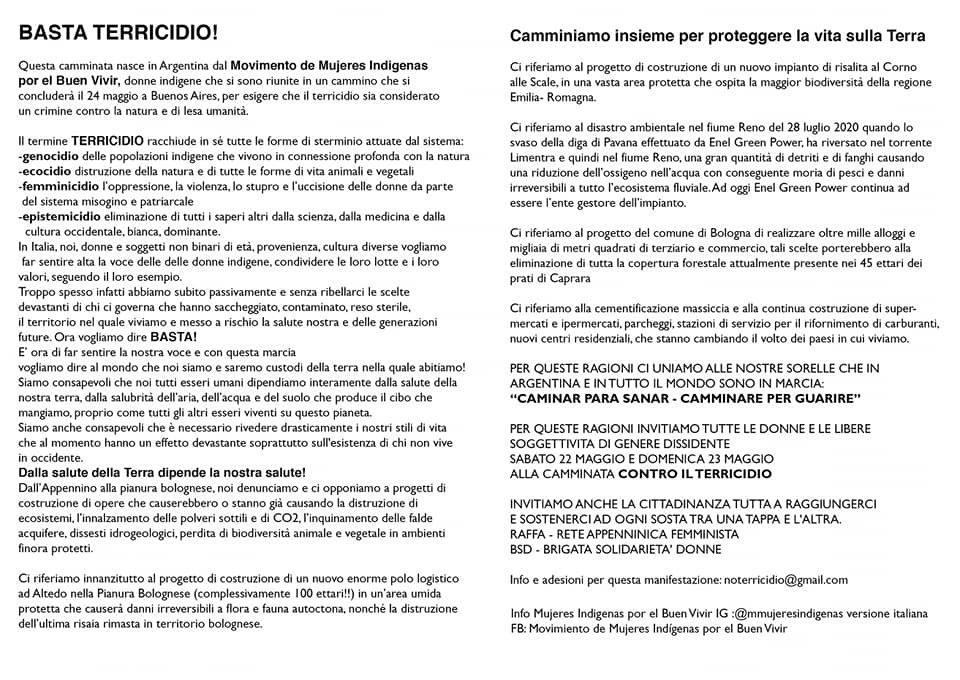*Questa immagine è della pittrice egiziana Shalabiya Ibrahim
Pubblichiamo la traduzione del testo di una compagna egiziana che fa un’analisi a dieci anni dalla rivoluzione.
Qua sotto il testo tradotto in inglese:
https://www.madamasr.com/en/2021/02/11/opinion/u/protection-siege-and-escape-what-my-body-has-done/
Qua sotto il testo originale in lingua araba:
كيف فعلتها يا جسدي| 10 سنوات في محاولة الخروج
(1)
Il mio corpo ha creato una dinamica particolare con la società intorno a me. E’ il muro alto dietro cui mi sono nascosta, e attraverso differenti periodi della mia vita sono stata grata per questo, per tutti i colpi che ha ricevuto al posto del mio cuore e della mia mente. Da quando ero piccola, la gente pensava che facessi sport violenti e dosava ogni parola che mi rivolgeva. Il mio corpo creava la distanza di cui avevo bisogno per proteggere me stessa e chiunque mi fosse vicino. Questa era una comodità per le mie amiche, e suscitava invidia e bullismo occasionale nei giovani maschi. Feci un vero sforzo per imparare a fare sport violenti e soddisfare le aspettative degli altri. Man mano che la ragazza in me iniziava a sviluppare forme identificabili come femminili, aveva bisogno di difendersi sempre di più in un corpo che era provocante e disorientante per chi non riusciva automaticamente ad assegnargli un genere.
A volte, l’immagine che hai di te stessa è l’esatto opposto dell’immagine che gli altri hanno di te. Alla fine rinunciai a imparare sport violenti da adolescente, quando realizzai che semplicemente non mi piacevano. Nella mia gioventù ci fu un interesse crescente per il wrestling, ma non riuscivo a condividerlo, chiudevo gli occhi durante le scene violente nei film.
La mia mente scoprì la magia della lettura e il brivido della scrittura, del teatro e del cinema. Il mio cuore vinse questo round. Leggevo avidamente e scrivevo alle superiori mentre il mio corpo continuava a trasmettere il messaggio al mondo che ero capace di aggredire, quindi faresti bene a stare attento. Ci sono profonde perdite che scaturiscono dalla tua mente che si muove in una direzione mentre il tuo corpo si muove in quella opposta. Mi persi annegando nello stereotipo a cui il mio corpo invitava; lo feci perché pensavo che fosse più sicuro.
A un certo punto realizzai lo stato di assedio in cui stavo vivendo, semplicemente vivendo qui, ma anche l’assedio che avevo imposto al mio corpo plasmandolo a un personaggio che non avevo scelto. Questo personaggio era intrappolato nell’elogio costante che riceveva da familiari e conoscenti: una donna vale cento uomini. La nostra società ama comparare le donne agli uomini come se fosse una celebrazione, ma quello che viene celebrato è il potere che la società dà agli uomini. Col tempo la mia consapevolezza crebbe, e così fece la mia lingua tagliente quando contrastavo l’attacco dei “cento uomini” ogni volta che veniva menzionato. Ma l’assedio continuò in molti, molti modi.
La mia voce era un perenne campo di battaglia negli anni della mia adolescenza. Quando crebbi il suo tono diventò rauco. Non mi ero resa conto del cambiamento. Vivevo nella spontaneità di un corpo che stava crescendo sempre di più e una voce che si espandeva con una fastidiosa eco. Ma disturbava i miei genitori, che pensavano fosse inadeguata per una ragazza. Dovettero consultare scienziati e specialisti. Mi trascinarono dal dottore che, dopo aver esaminato le mie corde vocali, disse fermamente a mia madre: ” Non ha problemi medici, questa è semplicemente la voce che ha, non è necessariamente una brutta cosa,” Mia madre era imbarazzata mentre cercava di formulare la domanda successiva. Il dottore la anticipò argutamente: “Molte ragazze e donne hanno voci più profonde, e alcune sono anche cantanti!” La visita a quel dottore diventò un aneddoto familiare e decisi di cantare su prescrizione medica, anche se solo per le persone amate.
La mia voce era un campo di battaglia atavico. Alle superiori decisi che volevo scrivere e lavorai nella radio e nel giornalismo della scuola. Preparavamo le notizie del mattino, per farle leggere a qualcun’altra, qualcuna con una voce più femminile della mia. La mia voce mi coinvolgeva in situazioni quotidiane: casuali conversazioni di corridoio con i miei colleghi – che fossero serie o divertenti – avrebbero sollevato un polverone. Le professoresse odiavano il modo in cui mi esprimevo e commentavano aspramente e aggressivamente con autorità materna legittimata.
Ma i professori erano divisi in due schieramenti, uno non sopportava che la tonalità della voce di una studentessa fosse più profonda e più forte della loro. L’altro schieramento controllava tutto quello che facevo in classe e fuori. Ero soggetta a un comportamento vendicativo di uno di loro: era un professore biondo, si vantava perché aveva la pelle più “chiara”, aveva un fisico abbastanza grosso con dei baffi biondi prominenti e una faccia oltremodo arrossata. Gli studenti temevano la sua voce, e quindi era responsabile della sicurezza a scuola e della mensa. Rincorreva le studentesse con un lungo bastone, di almeno mezzo metro, lo usava per colpire i loro corpi quando riusciva a raggiungerle mentre fuggivano da lui nel cortile dopo l’intervallo. Noi eravamo un gruppo di studenti che riuscivano a sfuggire a questo trattamento perché l’amministrazione sapeva che lavoravamo nel teatro e nel giornalismo e rappresentavamo la scuola nelle competizioni. Ci dava potere, barattavamo lavoro duro con momenti di misfatti.
Questo professore era un molestatore patriarcale che godeva dell’autorità senza limiti: autorità che non aveva sulla materia che si supponeva dovesse insegnare. La nostra relazione era silenziosa e resse finché trovò una falla: il mio contributo all’edizione di una rivista sulla Guerra del Golfo del 1998. L’uscita si chiamava “La voce delle studentesse” . Lo comunicò alla direzione scolastica e mi rinchiuse per un po’ di tempo nella “cantina“ della scuola. Da solo, raccolse tutte le copie di questa rivista alle studenti. Passarono ore prima che lasciassi finalmente la mensa dopo che alcune ragazze erano riuscite a nascondere qualche copia, e dopo che l’amministrazione aveva rifiutato la sua richiesta di espellermi, per motivi burocratici, alla fine della giornata. Dopo, nell’arco di tre anni, scoprimmo che aveva molestato tante studentesse, ma nessuna si sentiva di sporgere denuncia contro l’insegnante responsabile della sicurezza. L’amministrazione della scuola – costituita principalmente da donne – lo vedeva come il pastore che si prende cura del gregge.
Arrivai a odiare la mia voce e i problemi che mi causava. Questo mostro doveva essere contenuto perché la mia vita potesse migliorare, e le noie potessero finire. Ci provai per un po’ di giorni e poi me ne dimenticai. La mia tonalità aumentava con l’entusiasmo e la rabbia e continuai a sentire gli stessi commenti odiosi. La smisi di provare a cambiare quello che non volevo cambiare! Pagai un prezzo alto per aver preso quella strada e finalmente smisi di provare per sempre all’università quando scoprii la possibilità di lanciare slogan nelle proteste.
Lanciare slogan politici mi ha portato alla rivelazione che la mia voce non veniva dalla mia gola, ma piuttosto dal mio sentire, dalle parole che scaldano i cuori e infuocano gli animi. In pochi secondi, si stese un ponte e un processo di riconciliazione iniziò. C’erano più uomini che donne alla maggior parte delle proteste, e cantavano i cori più interessanti e orecchiabili. Erano pronti, portati sulle spalle, sopra le masse di teste umane, come i maestri di Sufi, e le ondate di giovani che desideravano un ruolo di spicco nel canto comune sarebbero corse in avanti verso di loro. I contributi delle donne erano scarsi fin a quando la mia generazione – pronta alla competizione – apparve. Donne che urlavano slogan e canti. Tra loro, la mia voce era pronta a elevarsi e quando lo faceva, mi trovai improvvisamente in un momento di celebrazione personale.
Il mio piacere ritrovato fu comunque rovinato dai partiti islamisti – Fratelli Musulmani inclusi, se gli capitava di unirsi a una protesta a cui partecipavo prima della rivoluzione- che rifiutavano di cantare dietro una donna. Ogni volta che alzavo la mia voce, il loro improvviso silenzio cercava di sconfiggermi. Il loro rifiuto era seguito dal suono di un uomo che cantava per guidare la sua gente e le loro voci si alzavano potenti dopo il loro silenzio. Tutto cambiò quando arrivò il momento giusto. Nella più oscura rabbia, i fiumi di contestatori non erano interessati al genere di chi intonasse. La mia voce ed io ci confrontammo con l’incontro più intimo mai verificatosi tra di noi. In uno di quei giorni di gennaio, dieci anni fa, la mia voce si alzava quando cantavo per le persone che non conoscevo, che non mi conoscevano. Sentivamo voci di donnne che cantavano lungo ogni strada che portasse a piazza Tahrir, e questo era uno dei segni della rivoluzione.
(2)
Iniziai a lavorare nel giornalismo con lo stesso atteggiamento, costruendo muri tra me e i miei colleghi in una professione la cui storia era in parte scritta da Fathy Ghanem. La mia generazione di giornaliste ereditò la sua storia su come alcune donne avevano costruito le loro carriere salendo sulle spalle dei loro amanti: i grandi guru della professione. Queste storie tossiche inquietano ogni giornalista di successo che potrebbe procurarsi un po’ di spazio di pubblicazione o farsi un po’ di reputazione. E’ implicito che una giornalista non ha altro da offrire oltre al suo corpo ai maschi che esercitano la sua professione. Motivo per il quale la possibilità di pubblicare per le giornaliste principianti viene ridotta. Ho visto uomini sommergere donne con sorrisi venefici, mentre altri le incontravano privatamente nei loro uffici, pronti a balzare sulla preda al minimo cenno di lasciapassare, o forse anche senza. Le giovani giornaliste si sedevano al di là della scrivania dei loro capi maschi, tremanti e caute. Alcune cercavano di aggirare la situazione, altre declinavano gentilmente. Le manipolatrici continuavano nei corridoi dei giornali; nelle sale stampa si parla di giornaliste stupende, gli uffici scoppiettanti di voci maschili come in un ring di wrestling che valutano i corpi delle nuove giornaliste. Il capo dipartimento che pubblica di questioni femminili siede nell’unità d’inchiesta circondato dal suo coro di editori maschi che controllano i corpi delle colleghe quando camminano nei corridoi dell’ufficio. Era molto difficile che una giornalista riuscisse a svincolarsi da tutti i genitali maschili che si trovavano ovunque.
Ho sentito storie dalle icone della generazione contemporanea di giornalisti, storie sui tycoon di questa professione, storie di molestie e violenza sessuale e storie di passione scambiata sul corpo di una moglie imbrogliata, o su convincere una donna dopo averle dato la caccia per mesi e anni perché era una proprietà di cui vantarsi. Ora, dopo che siamo stati inondati di testimonianze di violenze sessuali, ho sentito la stessa gente docilmente dire: “La violenza non è mai esistita ai nostri tempi!” Arriverà il giorno in cui i valori del giornalismo egiziano, costruiti sullo sfruttamento e sul rifiuto, crolleranno.
Una mia amica di una settantina d’anni mi racconta la storia dolorosa di come amava il giornalismo e di quanto tenesse al suo lavoro che ha fatto per poco tempo come inviata dopo l’Università. Poi finì la sua carriera dopo aver sposato un suo collega, un giornalista più grande, della rivista per cui lavorava, perché lui era uno scrittore brillante. Non importava quanto lei lavorasse duramente, avrebbero sempre detto che aveva fatto carriera sulle sue spalle. Ha lasciato il suo sogno sotto assedio là, nei corridoi degli uffici del giornale fino ad oggi.
All’inizio del mio impegno in politica e nel giornalismo, non esistevano conversazioni serie sulla violenza sessuale, neanche tra compagne. La nostra esperienza era giovane e fresca e idealista. Cantavamo contro le prigioni che non conoscevamo, e cantavamo per la libertà senza conoscere il pesante prezzo che avremmo pagato. Abbiamo ereditato una storia dell’attivismo che accettava gli interrogativi. Col tempo, le storie buie che ogni donna attivista ha avuto con gli uomini nei movimenti politici vennero alla luce, dallo sfruttamento sessuale alle complicate infedeltà dei mariti. Quello che era chiaro allora era che le donne non condividevano quelle storie tra di loro. Sono rimaste segreti oscuri, che macchiavano solo le donne coinvolte. Gli uomini monopolizzavano le narrative di queste relazioni mentre le donne venivano isolate e tagliate fuori anche dalle loro compagne di genere.
Va da sé che dato che gli uomini controllavano queste storie, la violenza e lo sfruttamento sessuale erano cause abbandonate. Ancora peggio, prendere a cuore queste questioni era considerata una distrazione per quelli che lavoravano nello spazio pubblico e nell’attivismo politico. Questo è più evidente nei commenti delle figure di spicco, uomini e donne di sinistra degli anni 70, quando l’opinione pubblica si interessa di una testimonianza di violenza sessuale per qualche giorno. Finalmente, qualcosa che mette nasseristi e comunisti sullo stesso piano.
Le nostre madri politiche non aprivano lo scrigno dei loro segreti come stanno facendo le donne di questa generazione . Pochissime donne delle generazioni precedenti mostravano le loro ferite. Una di queste era Arwa Saleh che ha lasciato il nostro mondo da una finestra, lasciando dietro di lei narrativa con cui la nostra generazione si è confrontata, rialzandosi dalle sue macerie. Ci ho pensato tante volte. Arwa se ne andò solo perché poté parlare? Parlare ci salva o ci uccide?
Molte donne degli anni settanta coprirono con matrimoni o famiglie che sembravano stabili vite che stavano effettivamente implodendo. Hanno fatto uno sforzo verso modelli normalizzati e tradizionali di relazione, a dispetto delle loro richieste di progresso politico. Forse volevano difendersi o semplicemente sovvertire lo stereotipo, sostenuto dalle virtuose autorità dello stato, che i comunisti sono pervertiti.
L’unica battaglia che ho attraversato in cui uomini dell’opposizione erano interessati alle violenze sessuali fu il giorno in cui le donne che protestavano furono molestate sessualmente al sindacato dei giornalisti, un giorno che venne chiamato il Mercoledì Nero del 2005. Le sopravvissute e le solidali decisero di far scoppiare il caso a livello locale e internazionale, e le loro vite diventarono un inferno perché insistevano nel perseguire i loro predatori. Anche se l’opposizione usò questo fatto per mettere in imbarazzo il regime, non è mai diventata una causa politica da inserire nella nostra agenda politica. Le violenze contro le donne sono rimaste secondarie anche nella scuola dell’attivismo contemporaneo. Il diffuso stato di negazione che ha imperato nell’opposizione di fronte alle richieste di donne che erano state aggredite sessualmente da attivisti, giornalisti prominenti e artisti non è per niente strano. Accusano le donne di sabotaggio, di cospirare contro il movimento e di lavorare per gli apparati di sicurezza: putride accuse a oggi ancora in voga.
E’ solo dopo che le donne si sono fatte avanti con testimonianze di molestie e stupri negli ultimi anni che i partiti liberali e di sinistra hanno adottato regolamenti e statuti per sanzionare gli abusi sessuali, nonostante la nascita dei partiti risalga alla fine degli anni settanta. E’ più probabile che, prima di questo momento, tali casi non venissero presi seriamente in considerazione. Mentre gli slogan politici dominavano il momento rivoluzionario, centinaia di donne stavano facendo degli sforzi enormi per formare gruppi di lotta contro le aggressioni sessuali in Piazza (Tahrir). I gruppi rivoluzionari risposero a questa autorganizzazione con aggressività; alcuni di loro andarono così avanti con il loro rifiuto della violenza che stava accadendo, che pretendevano che le violenze fossero provocate per macchiare l’immagine della Piazza. Ma, dato che le violenze continuarono a ripetersi e, dopo che abbiamo visto cose che avremmo voluto cancellare dalla nostra memoria per sempre, la negazione non è stata più possibile.
Ricordo una notte al Sindacato dei giornalisti quando le donne per la prima volta menzionarono i test di verginità a cui erano state obbligate a sottoporsi dai militari egiziani dopo che erano state arrestate, sopportare la crudeltà di questa orribile ispezione fisica in pieno momento rivoluzionario. Vennero messe in dubbio, diffamate e le loro storie vennero negate. Se non fosse stato per loro, questo crimine non sarebbe diventato di pubblico dominio non avremmo mai conosciuto l’alto prezzo che le donne hanno dovuto pagare per prendere parte alla rivoluzione egiziana. Ci racconta molto cosa affronta la donna egiziana nella sua lotta attuale: infatti l’uomo che aveva difeso questa pratica ora è diventato il presidente e dà il via libera ai suoi uomini a invadere le vagine delle detenute. In questo momento le donne stanno lottando su tutti i fronti. Siamo di fronte alla più grande ondata di presa di parola delle donne su se stesse e sui problemi che affrontano. Non è stato facile. Stanno pagando il prezzo con la diffamazione e la prigionia, perché hanno osato allontanarsi dal sistema di valori falsi associati alla famiglia egiziana. Alla luce di eventi recenti, le conversazioni sulle relazioni consensuali, lo stupro coniugale e la ridefinizione di molestie e violenza sessuale si stanno riaprendo. Non avremmo osato discutere di queste questioni in pubblico, ora è invece uno dei segnali più grandi che qui c’è stata una rivoluzione.
(3)
Per anni ho vissuto sotto la pelle della ragazza che poteva picchiare chiunque in un qualsiasi momento.
Il mio corpo era allenato allo scontro, abituato dagli incontri quotidiani per la strada, dentro la metropolitana o mentre svolgevo il mio lavoro di giornalista in strada. Dopo essere stata costantemente generosa nell’usare la mia energia fisica quando io e chi avevo accanto si sentiva minacciata, ho realizzato che non era la parte migliore di me. A volte spingevo il mio corpo, forzandolo, a entrare in scontri pesanti, da cui usciva esausto e incapace di comprendere la violenza subita. Ci ho messo anni per capire tutte le strategie di difesa di questo corpo.
Mentre ricordavamo, insieme ad amicx, episodi passati condivisi, ho scoperto che dopo ogni scontro violento avvenuto, mi dimenticavo momentaneamente dell’accaduto. Le persone amiche raccontavano di azioni che avevo fatto di cui non ricordavo. La mia mente rinnegava tutte le mie azioni, mentre cercavo di ricordare la situazione, davanti a me vedevo solo un buco nero senza fine. Il mio corpo si ricordava da solo, di una frustata sulla schiena o di una spalla indolensita e se lo teneva per sè.
Mi sono accorta di averlo usato come scudo protettivo dal vero dolore, mentre il corpo lo ha messo da parte per farlo uscire nel momento opportuno.
Quando ciò accade, nessun antidolorifico può alleviarlo. Mentre il corpo parla, l’essere umano può solo riconoscere la sua verità. Il corpo richiama il trauma di un momento passato nascosto che pensava di aver superato.
Il mio inconscio si ricorda alcuni di questi momenti, sento delle forti scosse, perchè come disse lo scrittore vietnamita Vu Tran: “Ciò che dimentichi subito, è fatto per essere ricordato di più dopo“
Può questo voler dire che sono forse sopravvissuta alle conseguenze di un abuso? Di sicuro no.
Abbiamo bisogno di fare un lungo viaggio, da cui non sappiamo come ne usciremo, se curando e sviscerando le zone del dolore o se invece la situazione sarà complessa prolungando la sofferenza nel silenzio?
Forse sono sopravvissuta agli abusi e le molestie abituali sia all’università che nel luogo di lavoro. Ma mi sono dovuta confrontare con le prese in giro, il bullismo e gli sguardi increduli che si domandavano chi ci fosse dietro a questo strano corpo che passava attraverso uno stormo di occhi dall’atteggiamento feroce. Occhi che cercavano nel mio corpo un segno di femminilità che veniva distrutto dalla mia voce.
Aumentava lo sconcerto nel momento in cui agivo in modo spontaneo e sicura di me, si pensa che il farsi avanti e l’irruzione appartengano ai maschi, mentre la donna deve essere timida e aspettare la salvezza da qualcuno. Quando sono ormai arrivati alla scoperta del genere, si passa alla fase “è una donna che vale come cento uomini” per esprimere ammirazione o alla fase “è una donna mascolina” per sottolineare e condannare la stranezza del mio corpo.
Questa era una salvezza che sapeva di annegamento.
La memoria del corpo è confusa, preserva alcune sensazioni senza avere una visione complessiva. Mani che toccano ogni parte sensibile del tuo corpo è una sensazione mostruosa e violenta. Questo momento non se ne va, nè diminuisce l’impatto con il passare degli anni.
Tutte le persone sono state picchiate durante le manifestazioni che si trasformavano in attacchi da parte della polizia. I nostri corpi venivano colpiti di più. Ogni predatore sa perfettamente come colpire le donne e inoltre come colpire il senso di mascolinità dei loro uomini. Nascondere ciò che accade è a volte un’ottima soluzione per disfarsi della pesantezza del momento.
Questo cerchio infernale continua a girare efficacemente.
Come donne che abbiamo vissuto la maggior parte degli eventi politici di questo paese, negli ultimi venti anni, nessun incontro pubblico è sicuro per noi.
Nemmeno durante il picco dell’euforia collettiva, il giorno in cui Mubarak si è dimesso, era sicuro per noi. La sera lo stato di utopia era finito e dava spazio a una nuova fase più estenuante e violenta.
Come molte donne che hanno subito ferite lievi o pesanti durante gli scontri, come gas lacrimogeni, pallottole di gomma, abusi sessuali o verbali, spesso mi sono ritrovata a scontrarmi con il corpo. Nel quarto anno dopo l’inizio della rivoluzione, ogni tanto il mio corpo ha iniziato a darmi segnali di debolezza, la cosa non mi stupiva.
Mi sono comportata come se nulla fosse, fino a negare la natura delle malattie. Pensavo che bastasse curarmi per qualche settimana per rimettere in sesto quello che non funzionava. Ma questo non bastava, la mia vita ogni tanto si fermava e a volte non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto, senza l’aiuto di qualcuno. Con il tempo ho scoperto di avere tre malattie croniche (la pressione alta, delle ernie e la sinusite cronica). Avevo appena trenta anni.
Ero arrabbiata con il mio corpo, continuavo a rifiutare che cadesse e si fermasse nel pieno della giovinezza. Ma non ero un caso a parte, tutte le persone intorno a me soffrivano. Non c’è miglior definizione se non “stress post-traumatico”. Il mio corpo si esprimeva rispetto a quello che la mia mente non riusciva ad elaborare velocemente. Ho seguito il dolore, ho ricordato forzatamente alcune situazioni e ho trovato la sua vera origine.
Ogni volta che il dolore al collo aumentava, sentivo ogni botta che aveva preso. Un momento in particolare è uscito dal profondo della memoria. Durante la manifestazione dopo l’assassinio di Khaled Said, mi avevano accerchiata un gruppo di informatori e poliziotti, all’entrata di Qasr Ismail nel quartiere al-Mounira,e hanno iniziato a picchiarmi selvaggiamente. All’inizio ho cercato di rispondere all’attacco, ma poi ho deciso di difendere la mia testa e i miei vestiti che comunque sono stati strappati poco dopo. Le vertebre del collo si sono presi tutti i colpi. La memoria del mio corpo ha immagazzinato questo momento, senza passare per la mente che ha cercato di negarlo. Dopo aver evocato questa scena, ho osservato i movimenti del mio corpo a ogni attacco ricevuto e ho preso coscienza del fatto che le vertebre del collo per anni si sono portate addosso le conseguenze di qualsiasi scontro violento che ho vissuto.
Sulla base di questa esperienza, ho preso coscienza dei restanti ostacoli del mio corpo. Mi sono rivolta alla mia anima per cercare di ripararla dal ricordo degli attacchi che pensavo di aver superato.
È stato un lungo viaggio. Il sostegno delle amicizie, di una rete di solidarietà magnifica, le esperienze condivise per oltrepassare il dolore, erano e sono tutt’ora l’unico raccolto durante gli anni di una terribile dittatura.
Ora, prendo coscienza di cosa ho dato alla rivoluzione e che strumenti mi ha dato per curarmi.
Senza tutti i sorprendenti accadimenti avvenuti e che continuano finora ad avere una eco diretta, spingendo questa società a ribellarsi da gennaio del 2011, sarei rimasta imprigionata in un corpo senza conoscerlo dentro alla bolla del lavoro politico senza senso, il quale non vede che la libertà di questo paese passa dall‘incolumità e libertà del mio corpo.
Nella ricorrenza dal decimo anno della rivoluzione, mi ritrovo a disegnare dei confini tra un momento passato senza la possibilità di ritorno e la speranza infinita di un incontro prossimo con la mia nuova voce.